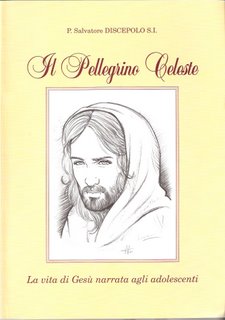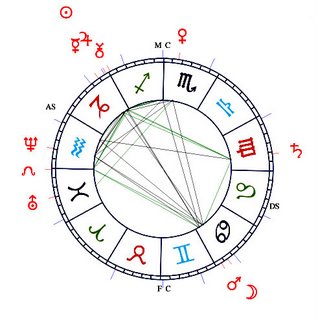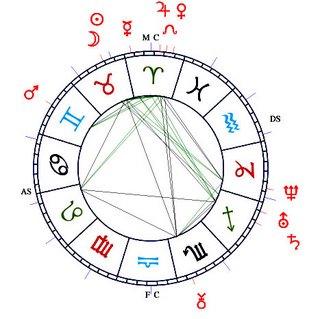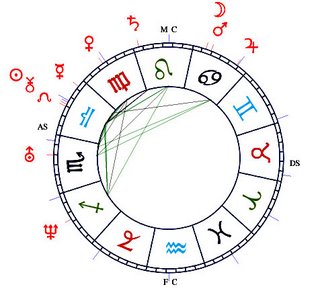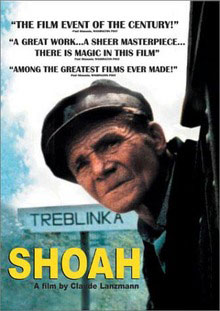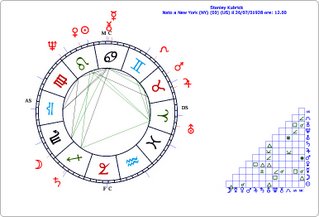Compleanno in Pakistan

Avevo un piano ben preciso perché conoscevo i pericoli del posto e anche la bruttezza dello stesso e con questo non voglio offendere i pakistani che vivono in luoghi anche stupendi.
Karachi è una megalopoli mostruosa, soprattutto per affollamento, per inquinamento e per densità di povertà e di malattie gravi ormai divenute endemiche.
Giunsi all’aeroporto intorno alle dodici del mattino, ma all’aperto il sole infuocava già tutto ed eravamo, certamente, oltre i 45°C all’ombra. Con un taxi mi diressi allo Sheraton al centro della città, non molto costoso lì come in quasi tutta l’Asia. Attraversai un’unica enorme, sterminata, strada che dall’aeroporto conduce al centro di quella che molti credono sia la capitale del Pakistan, ma che è solo la città più importante di quel Paese.
Per darvi un’idea, pensate agli Champs Élysées. Una strada molto più larga e molti chilometri più lunga, ma non erano gli Champs Élysées. Migliaia di motorini, furgoncini tipo Ape e piccolissimi bus pubblici e privati con i viaggiatori appesi ai finestrini o ammassati sui tetti dei veicoli intasavano completamente il traffico. Si aveva l’impressione come di un esodo di massa per motivi bellici, ma era un giorno come un altro, come mi spiegò il tassista. Praticamente non si procedeva di un solo passo e solo ogni 10-12 minuti si avanzava di pochissimo. Stare in una camera a gas sarebbe stato meno velenoso. Il caldo insopportabile, il rumore assordante, il gas e la vista di quei disperati aggrappati ai veicoli, tutto contribuiva a farmi comprendere com’è l’inferno, se esiste un inferno oltre quello terrestre.
Finalmente giunsi in hotel e scelsi un piano altissimo per una regola che seguo sempre in posti ad alto rischio terroristico. Infatti, soltanto un anno dopo, un gruppo di sei o sette francesi, se ben ricordo, nello stesso hotel, fu massacrato da un’esplosione di un furgoncino kamikaze davanti alla porta d’ingresso.
Mi chiesi come mai le finestre avessero orribili inferriate nere, come in carcere, ma l’interrogativo durò poco perché guardando fuori vidi che migliaia di enormi corvi neri volavano su Karachi e, evidentemente, le inferriate servivano a non avere in camera ospiti sgraditi.
Il Pakistan, come si sa, è in guerra da sempre, soprattutto con l’India, e dunque non mi sorpresi nel vedere che, seduto su di una poltroncina, a ogni piano dell’hotel, vi era un poliziotto in borghese che non tentava di nascondere un’enorme pistola infilata nella cintura dei pantaloni e pronta all’uso.
Avevo deciso di fermarmi solo 20 ore e così feci. Solitamente in questi posti (Karachi, Jakarta, Surabaya e molti altri) non è possibile fare la doccia perché l’acqua esce di colore marroncino chiaro e l’unica è portarsi da casa dei fazzoletti detergenti con cui lavarsi. I denti vanno lavati esclusivamente con acqua minerale sigillata o con whisky.
Scesi al ristorante interno all’hotel soltanto per la cena.
Mangiai, come quasi sempre in Oriente, bistecca ai ferri, molto cotta, e patatine fritte. Poi chiesi “Pineapple in a metal box” (ananas in scatola). Il capocameriere continuava a chiedermi incredulo se aveva capito bene e mi mostrava un tavolo grande pieno di frutta fresca di ogni tipo. Per non offenderlo non gli dissi che quella frutta la poteva mangiare lui e che io preferivo le ananas in scatola delle Azzorre, magari.
La mattina dopo, alle otto, ero di nuovo in aeroporto.Non ricordo se all’andata o al ritorno, nel corso di una delle innumerevoli soste, assistetti a questa scena: la scena del dentista. Non so se in quel paese esistano o meno i dentisti come da noi, di certo esistono i dentisti ambulanti, lungo la strada, a fianco alle auto, senza un solo albero e sotto un sole che avrebbe bruciato anche un abitante di Jeddah. Un poliziotto si avvicinò al “dottore” e gli fece segno che gli doleva fortemente il dente. L’altro, con aria professionale, seppure ricoperto di stracci, gli osservò l’interno della bocca, dopo averlo fatto sedere su di un piccolo sgabello.
Aprì una borsa e rovistando tra ferri non sterilizzati, ma molto arrugginiti, tirò fuori una tenaglia e così, senza pensarci e senza anestesia, tirò con quanta forza avesse in corpo e ottenne il dente malato insieme a uno spruzzo di sangue in faccia dove immagino ci fossero tutti i virus delle varie epatiti, dalla A alla Z, comprese quelle ancora da scoprire.
Giunto in aeroporto il poliziotto osservò il mio passaporto e si avvide che ero giunto lì 20 ore prima.
Mi chiese per quale motivo fossi venuto a Karachi.
“Tourism”.
“Tourism? One day, in Karachi?”.
“Yes, tourism, one day, in Karachi”.
E lui fece quel gesto internazionale con la mano che significa: aspetta che ti sistemo io.
Chiamò altre due guardie e mi fece portare in uno stanzino dove fui spogliato completamente e perquisito. Anche i miei abiti furono sottoposti a controlli rigidissimi, ma alla fine mi lasciarono andare.
Un padre e un figlio italiani, esattamente una settimana dopo, si recarono a Karachi e seguirono il mio stesso piano, ma questa volta il poliziotto (forse lo stesso) fu molto più severo e scucì le fodere dei loro vestiti e tagliò a metà le suole delle scarpe, pur senza trovare nulla.
Anche in questo caso fu costretto a lasciarli andare.
Non ho nulla contro il Pakistan e contro i pakistani, ma spero di non dover mai più tornare a Karachi.
Ciro Discepolo
www.solarreturns.com
www.cirodiscepolo.it